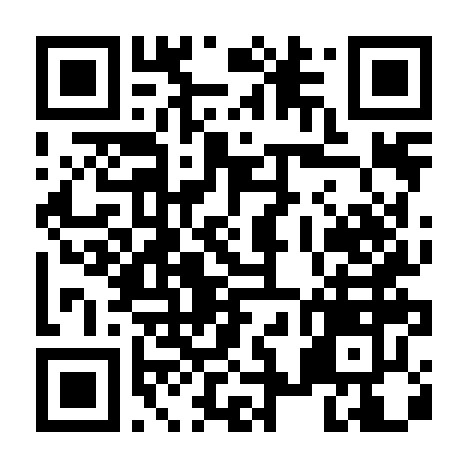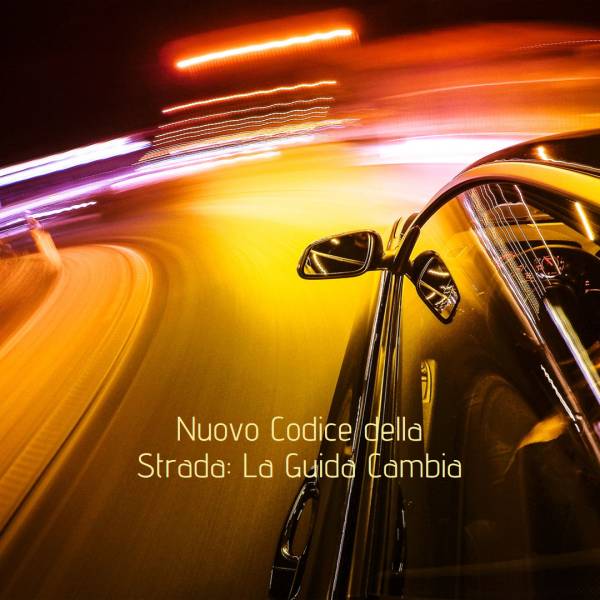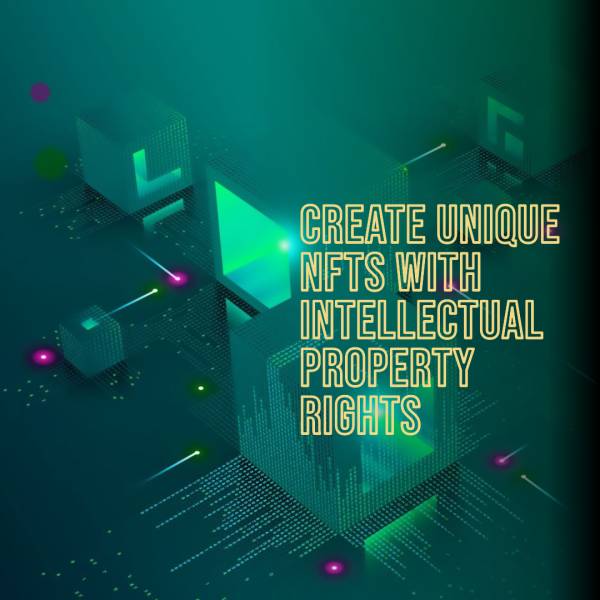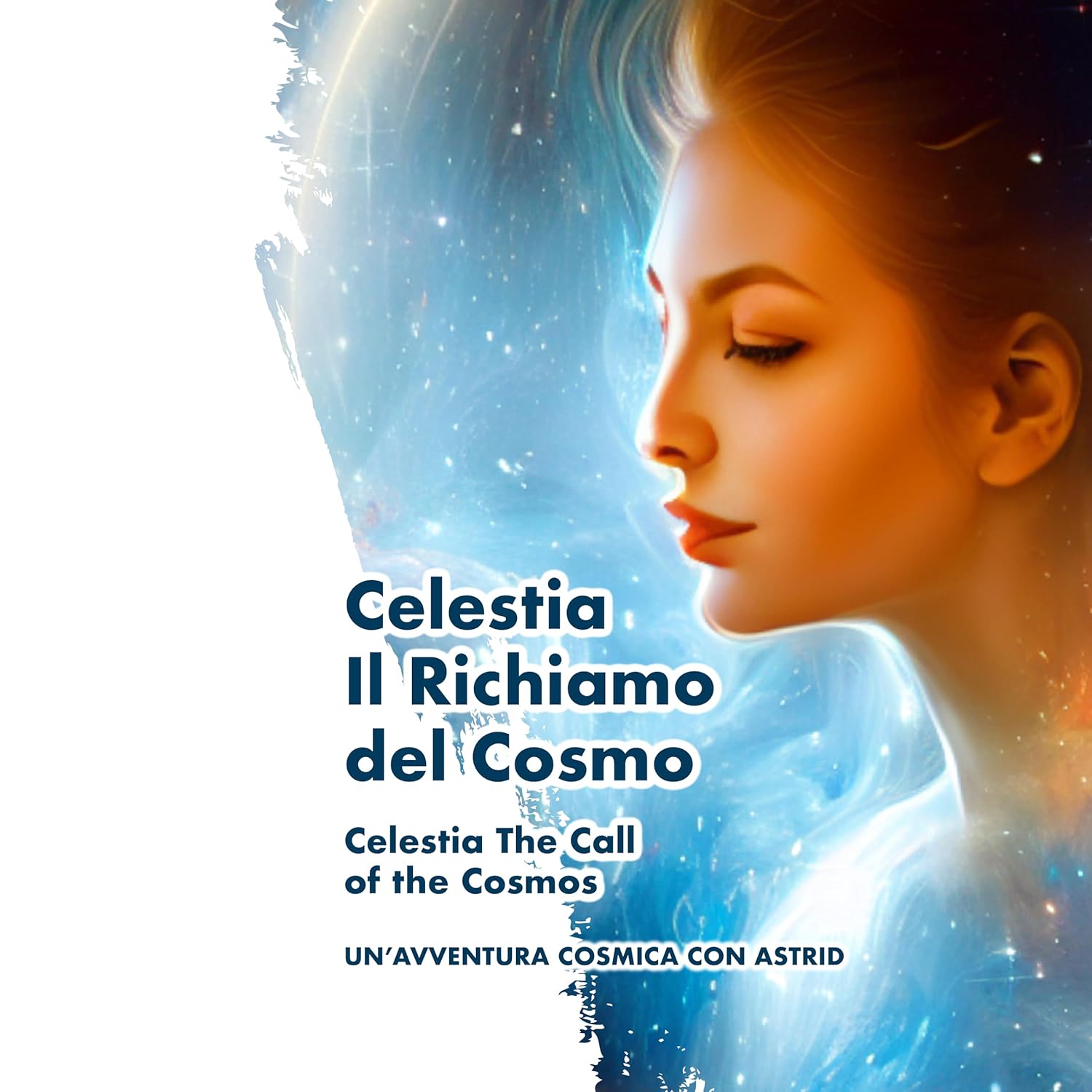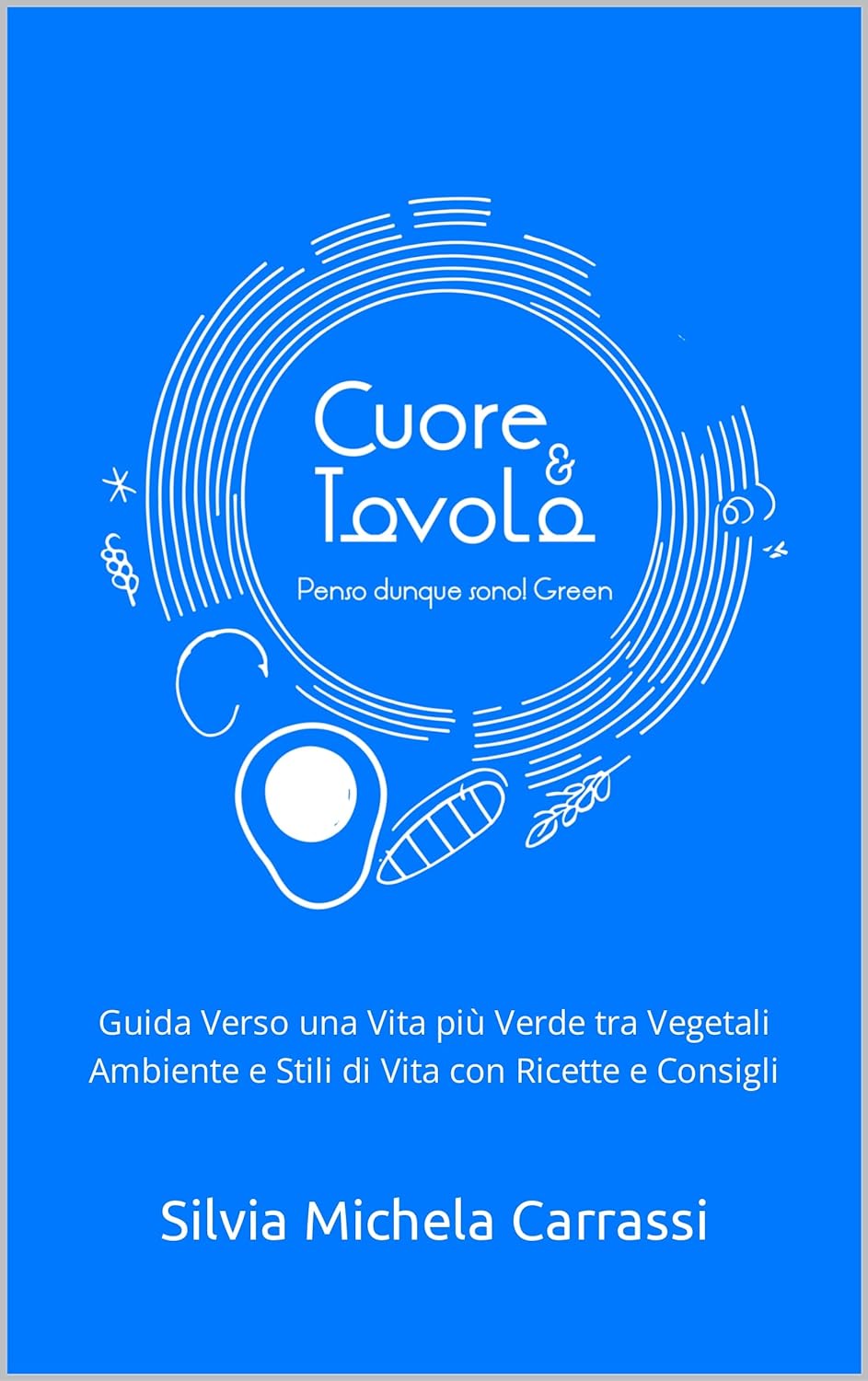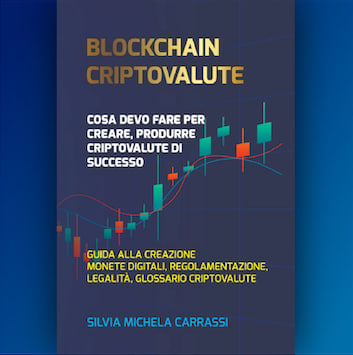parole 2.3K 9 minuti
0
0